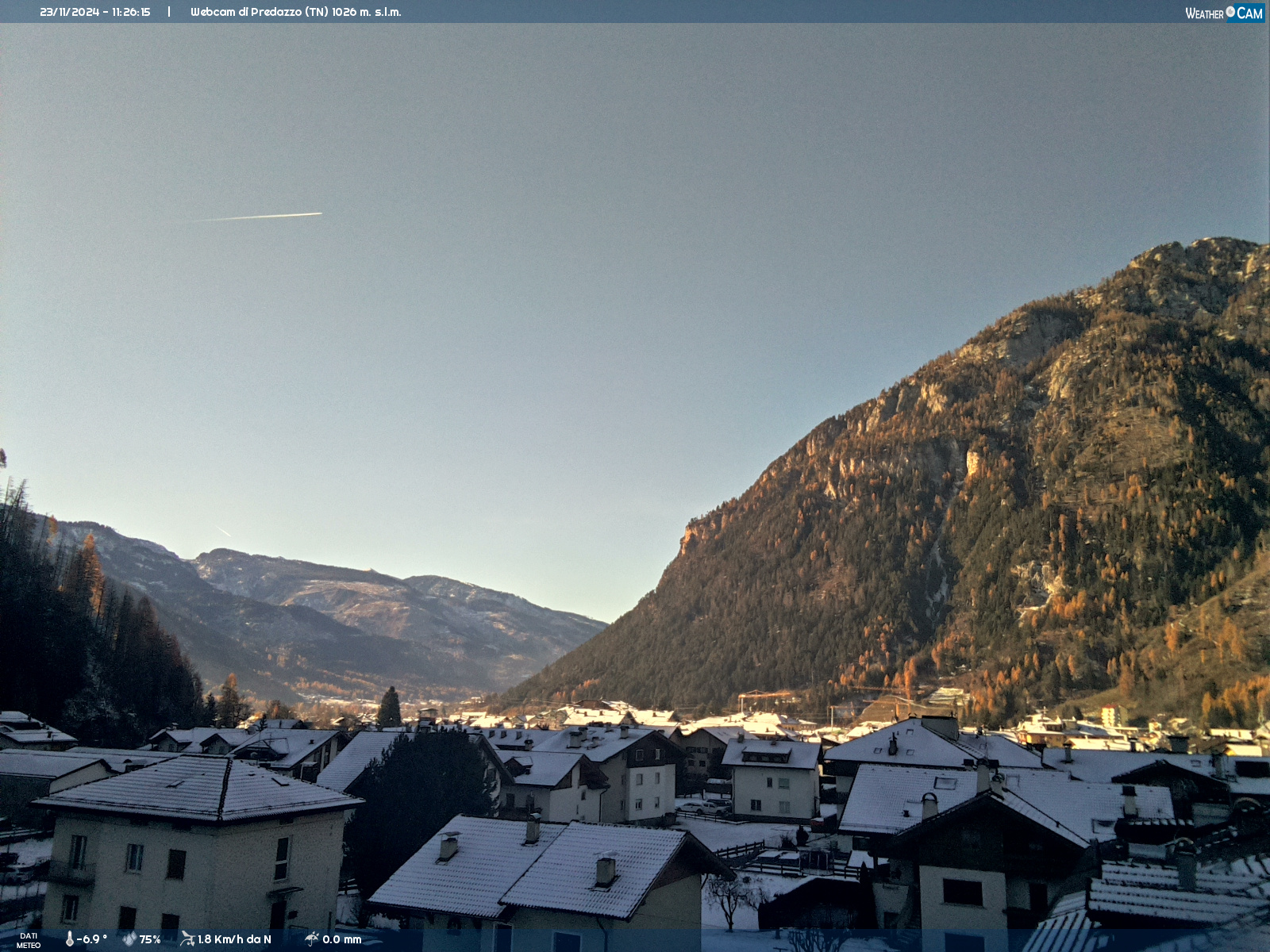Tutti schierati per scatenare la Terza Guerra Mondiale, ultimo appello del Papa per salvare il…
Kirov, la fossa comune dei soldati italiani dispersi in Russia

Vicino agli Urali riaffiora l’orrore dei soldati italiani prigionieri dei sovietici durante la seconda guerra mondiale descritto da Nuto Revelli nel libro La strada del davai, avanti, cammina, in russo.
A Kirov, a 800 chilometri a est da Mosca, è stata scoperta una fossa comune con i resti di soldati dell’Asse, probabilmente anche italiani.
Lungo una ferrovia, 500 metri di larghezza per 100 di altezza e 4 di profondità, colmi di ossa. Si potrebbe trattare di quindicimila uomini, morti durante la deportazione e in prigionia, dopo terribili sofferenze; e fra loro potrebbero esserci alcuni degli oltre 56 mila dispersi italiani in Russia.
Durante la disfatta di Russia furono uccisi in combattimento 20mila soldati italiani e ben 70mila morirono in prigionia e durante le famigerate marce del davai. Meglio note come marce della morte per raggiungere nella morsa del gelo e senza cibo i campi di concentramento. A Kirov sono arrivati i prigionieri ungheresi, italiani, romeni, tedeschi finiti in mani russe nel 1942-1943, durante e dopo la battaglia di Stalingrado e la liberazione di Voronezh. Nelle sacche provocate dal crollo dell’armata germanica è finito mezzo milione di uomini. E tanti non sono mai tornati a casa.
«I prigionieri catturati, prima li trascinavano a piedi nella neve per centinaia di chilometri. E poi li chiudevano in carri bestiame piombati senza cibo e acqua per giorni. Così morivano i prigionieri italiani dei sovietici, di stenti o di assideramento» racconta Guido Aviani Fulvio direttore del Museo della campagna di Russia in Friuli-Venezia Giulia. «I cadaveri venivano buttati denudati nelle fosse comuni come quelle di Kirov».
Uno dei soldati ritrovati nella fossa di Kirov è senz’altro italiano, a giudicare dalla piastrina dell’esercito italiano di cui il Giornale ha pubblicato ieri la foto. Un frammento di metallo corroso dal gelo e dal tempo, in cui a fatica si indovina, più che si legga: ‘classe 1922′. Tutto qui, nient’altro, il nome e il cognome e il grado cancellati da settant’anni sotto terra. ‘Classe 1922′, tutto ciò che sappiamo di questo povero milite ignoto. Anzi, un’altra cosa sappiamo: la ritirata italiana in Russia è del 1943, e dunque quello sconosciuto soldato aveva appena 21 anni.
La stessa età che ha oggi un tuo figlio, pensi con una fitta al cuore; e per questo sai bene che faccia, che occhi, e quanta vita addosso hanno i ragazzi, a quell’età. Pensi a sua madre, a suo padre, a quanto devono averlo aspettato: continuando a sperare, nel muro di silenzio piombato su quelle decine di migliaia di dispersi. Deve essere terribile non avere nemmeno un corpo su cui piangere: è come se il lutto si prolungasse, infinito. Mentre laggiù, in quelle lontane sconfinate pianure, i prigionieri venivano sepolti a centinaia, spogliati delle divise, ammucchiati come carcasse di bestie.
Senza nemmeno una croce. (L’hanno trovata, la fossa di Kirov, per caso, costruendo un quartiere di villette). E di tutti quegli uomini e ragazzi non ci resta un nome, nell’annichilimento più estremo. Solo qualche medaglietta della Madonna o di un santo, e quella piastrina arrugginita e disfatta. Quali demoni suscita la guerra, perché gli uomini finiscano nel nulla? Bisognerebbe mostrarla, quella piastrina, in tv e sul web, accanto a tante cose inutili o volgari o deleterie. ‘Classe 1922′, e nient’altro.
E chissà che occhi avevi, ragazzo, e che cosa pensavi mentre ti urlavano ‘davai!’, in russo ‘avanti!’ – avanti, come un gregge al macello. Chissà se pensavi a tua madre, e pregavi.
Marina Corradi
Questo articolo è già stato letto 63639 volte!