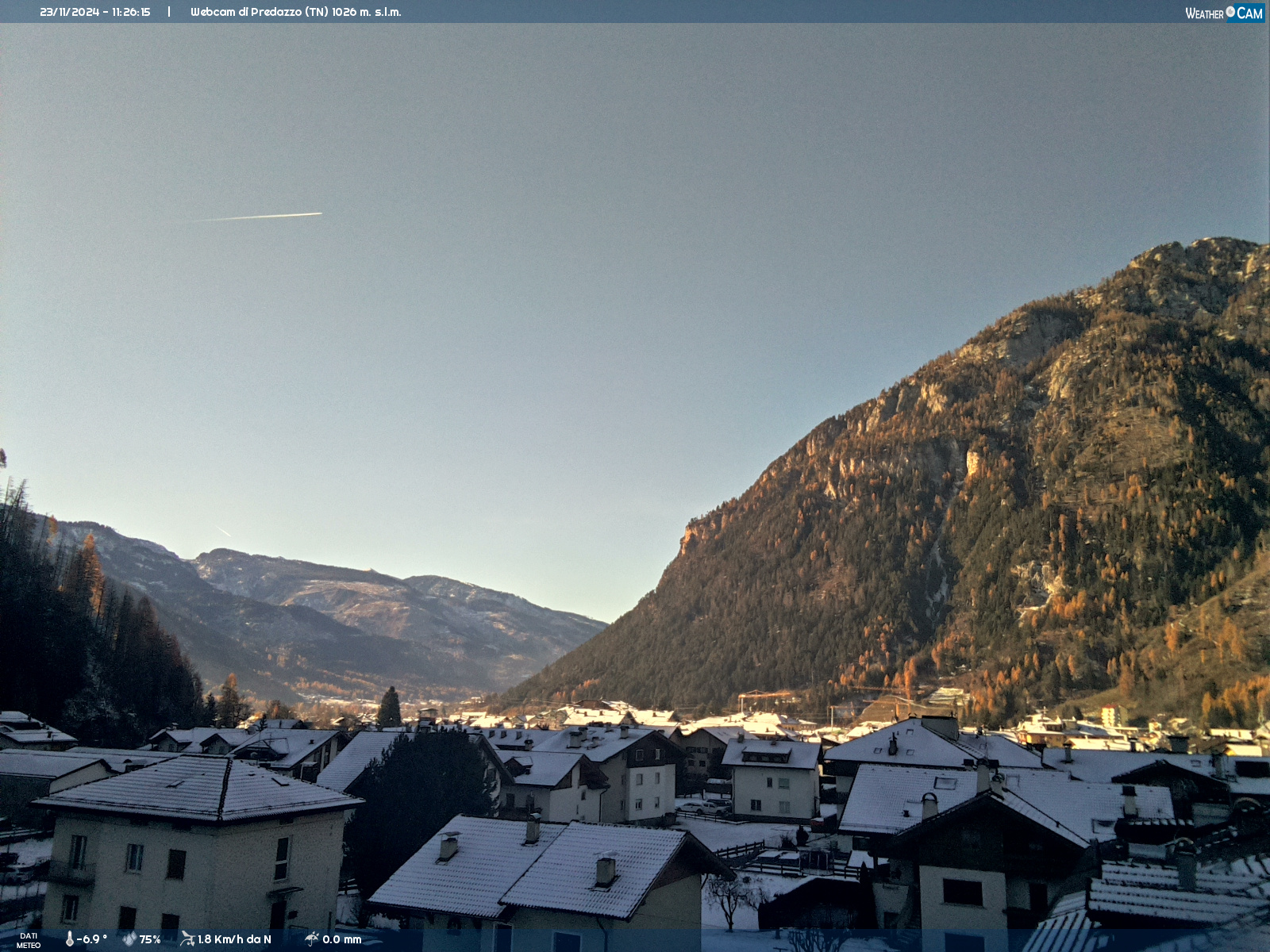I problemi dopo il violento terremoto in Giappone non sono finiti, anzi, quello che fa…
Acqua e nucleare, guida ai referendum del 12 e 13 giugno
Il 12 e il 13 giugno gli italiani saranno chiamati ad esprimere il loro parere su due temi fondamentali: l’acqua e il nucleare. Di seguito un vademecum per capire quali sono le principali questioni legate ai quesiti referendari e perché sarà di estrema importanza che almeno 25 milioni di persone si rechino alle urne
Di seguito cercheremo di capire perché è importante – ma più che importante fondamentale, essenziale – che il 12 e il 13 giugnoprossimi una gran folla di gente vinca l’apatia dell’afa estiva, si stacchi dal ventilatore e si rechi alle urne a votare. Mi scuso fin da subito per i toni un po’ più colloquiali e spicci di quanto si dovrebbe che userò nel corso dell’articolo, ma è bene intendersi fin da adesso: qui è in gioco una buona fetta del nostro futuro, e di quello dei nostri figli e nipoti.
Sono quattro i referendum in questione: due riguardano l’acqua, uno il nucleare, uno il legittimo impedimento. Di quest’ultimo non ci occuperemo in questa sede, dato che si tratta di un argomento molto circostanziato, che poco ha a che fare con gli altri due.
Iniziamo col chiarire un aspetto tecnico, che so per esperienza non essere così immediato. Chi vorrà affermare, in sede referendaria, che l’acqua è un bene comune e che il nucleare deve essere messo definitivamente al bando, dovrà votare per tre volte SI. Poi analizzeremo nel dettaglio cosa significa ciascuno di questi sì, ma vorrei fosse chiaro fin da ora che anche per dire no al nucleare va sbarrata la casella del sì. Se infatti è abbastanza intuitivo che si debba votare sì per l’acqua pubblica, potrebbe apparire un controsenso, a chi non abbia qualche nozione giurisprudenziale, barrare il sì per fermare il nucleare.
La ragione di questo apparente controsenso va ricercata nelle regole dell’istituto referendario. Sebbene nel nostro paese siano costituzionalmente previste quattro diverse forme di referendum, l’unica di fatto utilizzata è il referendum abrogativo. Quello cioè che chiede agli elettori se vogliono abrogare – ovvero sopprimere – una determinata legge o parte di essa. Tutti i referendum abrogativi iniziano così: “volete voi che sia abrogato” eccetera eccetera. Ecco quindi che per dire no al nucleare vi sarà chiesto di abrogare la norma che sancisce la sua introduzione nella legislazione italiana. Fatta questa doverosa precisazione andiamo ad analizzare più nel dettaglio i contenuti dei tre referendum.

L’acqua è un bene comune che appartiene a tutti
Partiamo dall’acqua, e scusatemi se mi dilungherò un po’ nelle spiegazioni, ma è giusto che chi andrà a votare abbia tutte le informazioni necessarie per prendere liberamente e consapevolmente la sua decisione. La mia esperienza ai banchetti di raccolta firme mi dice che molto poco si sa sul processo di privatizzazione da anni in atto in Italia. A chi volesse approfondire l’argomento, consiglio di leggere il libro di L’acqua è una merce di Luca Martinelli (lo trovate fra quelli consigliati in calce a questo articolo). Qui ci limiteremo a richiamare le due principali tappe della privatizzazione: la legge Galli ed il decreto Ronchi.
La legge Galli, numero 36 del 1994, suddivideva il territorio italiano in una serie di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) all’interno dei quali “l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” doveva essere gestito da un unico soggetto ‘affidatario’. Le caratteristiche dell’affidatario potevano essere le seguenti: una società per azioni a totale capitale pubblico (che prende il nome di in house); un partner privato da affiancare al vecchio gestore pubblico, scelto con gara aperta a tutti i concorrenti europei; un soggetto privato. La legge, inoltre, introduceva il principio del full recovery cost: sanciva cioè che tutto il costo della gestione del servizio idrico fosse caricato sulla bolletta e non rientrasse più fra gli ambiti della fiscalità generale (fatto di dubbia costituzionalità, visto che così il prezzo perde ogni rapporto con il reddito di chi usufruisce). In particolare veniva stabilito un addebito in bolletta che garantisse un 7% di guadagno minimo al gestore. L’acqua fu resa, di colpo, un investimento molto appetibile.
Il decreto Ronchi, decreto legge numero 135 del 2009, trasformata nella legge Ronchi-Fitto nel novembre dello stesso anno, ha completato l’opera di privatizzazione mettendo definitivamente al bando tutti quei comuni che avevano scelto la gestione in house. Si tratta di una legge sull’attuazione degli obblighi comunitari e i servizi pubblici locali che all’articolo 15 – quello incriminato – recita “adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica”. È chiaro fin da subito, dunque, che l’acqua è considerata alla stregua di una merce. Nella legge, poi, sono presenti alcune incongruenze che rendono chiaro come la tanto sbandierata “liberalizzazione dei servizi” si traduca in una svendita a favore dei grandi investitori privati. La prima viene definita da Daniele Martinelli “paradosso del mercato”: si prevede che tutti i soggetti privati scelti con affidamento diretto per affiancare i gestori pubblici mantengano le proprie quote, e che la partecipazione degli enti locali in queste società scenda sotto la soglia del 30 per cento entro il 2015. In altre parole, da un lato viene rivelato che alcuni soggetti privati si sono inseriti nella gestione pubblica dei servizi idrici senza passare per alcuna gara (come invece previsto dalla legge Galli); dall’altro viene concesso a tali soggetti di restare “in sella”, anzi di accrescere la propria partecipazione a discapito del pubblico, contraddicendo la legge del mercato (e della concorrenza) sul cui altare sono state sacrificate le gestioni in house. La seconda incongruenza viene definita “fallimento del mercato”: la legge prevede infatti che in alcune “situazioni eccezionali”, determinate da “caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale […] l’affidamento può avvenire a società a capitale interamente pubblico”. Ciò significa che il privato sarà libero di investire solo laddove ritiene possibile garantirsi un profitto.
Dopo questo excursus negli aspetti giurisprudenziali del processo di privatizzazione, occorre smentire alcuni luoghi comuni, confezionati ad arte, che circolano da tempo fra coloro che osteggiano i referendum e continuano a ripetere come un mantra che “privato è bello”. Eccoli di seguito.
Privatizzazione=efficienza, efficacia, economicità.Partiamo da quello forse più utilizzato dai fautori delle privatizzazioni: le famose “3 e” che caratterizzerebbero in positivo il privato rispetto ad un pubblico per assioma lento, inefficiente e caro. Partiamo dall’ultima “e”, l’economicità, dimostratasi fin da subito del tutto inveritiera. I comuni che hanno già sperimentato l’affidamento privato sanno bene che nella maggior parte dei casi le bollette hanno subìto impennate significative. In Toscana, una delle prime regioni ad adeguarsi quasi completamente alle norme di privatizzazione, si beve l’acqua più cara d’Italia, con un aumento tariffario che nell’ultimo anno è stato dell’11,8 per cento. L’aumento dei prezzi – che gli stessi fautori della privatizzazione si sono trovati costretti ad ammettere – viene generalmente giustificato con la scusa degli investimenti: le bollette sono più care perché sono stati fatti più investimenti per migliorare le reti idriche, che in Italia versano in condizioni disastrose (si perde quasi il 50 per cento dell’acqua potabile). Ma non è così. Gli investimenti necessari sono tanti di tale portata che nessun privato ha la capacità – e l’intenzione – di sobbarcarseli. Lo dimostra un’indagine di Mediobanca: il miglior acquedotto d’Italia – a livello infrastrutturale – è quello di Milano e provincia, gestito da Metropolitana Milanese (100% del Comune di Milano) e da Amiacque (100% pubblica); il peggiore è quello romano, gestito da Acea, una delle società più invischiate nel processo di privatizzazione, sulla quale hanno già messo le mani il Gruppo Caltagirone ed una multinazionale francese del calibro di GDF Suez.
Privatizzare=liberalizzare. Un’altra tecnica molto in voga al giorno d’oggi è quella di cambiare le parole lasciandone invariato il significato. Ecco quindi che i temibili inceneritori diventano dei più rassicuranti “termovalorizzatori”, ed ecco che le privatizzazioni diventano liberalizzazioni. Ma se già questa pratica di scambio è odiosa a prescindere, nel caso dell’acqua risulta persino spudoratamente menzognera. Quando si parla di liberalizzazione infatti, si parla di apertura al mercato e alla concorrenza. Nella gestione del servizio idrico, invece, non c’è nessuna concorrenza. Una volta che il privato si è aggiudicato la gara d’appalto, egli resta in una condizione di assoluto monopolio per 20-30 anni, la durata del contratto. Altro che liberalizzazione, qui si sostituisce il tanto biasimato “monopolio pubblico” – già di per sé una contraddizione in termini – con un ben peggiore “monopolio privato”.
Gestione privata=acqua pubblica. Infine ecco il più infido degli inganni, quello che vuole che ad essere privatizzata sia solo la gestione del servizio, mentre l’acqua, la sostanza, rimarrebbe un bene comune inalienabile. E ci mancherebbe! Nessuno sarebbe in grado, anche volendo, di appropriarsi e ingabbiare una risorsa che sgorga dalla terra e cade dal cielo. Ma ciò che interessa l’uomo nella sua vita di tutti i giorni è la sua gestione: chi porta l’acqua nella sua casa, a che prezzo e di quale qualità. Ci interessa che venga garantito a tutti il libero accesso alla risorsa. Che importa che questa sia formalmente di tutti se poi non tutti possono permettersela?
Ecco allora che per riaffermare la proprietà – o gestione che dir si voglia – comune dell’acqua sono stati elaborati due quesiti referendari (erano inizialmente tre ma uno non ha passato il vaglio della Corte Costituzionale).
Il primo richiede l’abrogazione dell’art. 23 bis Legge 133/08 e sue successive modifiche introdotte con l’Art. 15 del famoso Decreto Ronchi, di cui abbiamo già parlato prima (D.L. 135/2009); annullando tale articolo – che stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati o a società a capitale misto pubblico-privato – si vuole contrastare l’accelerazione sulle privatizzazioni e la definitiva consegna al mercato dei servizi idrici.
Il secondo richiede l’abrogazione della parte dell’art. 154 del Decreto Ambientale 152/06 relativa alla remunerazione del capitale investito; si tratta di un decreto che, integrando e in parte sostituendo la Legge Galli, stabilisce che “la tariffa è determinata tenendo conto [...] dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito [...]”; abrogando questa parte di articolo si annulla il principio del profitto minimo garantito, rendendo l’acqua un investimento non più così conveniente.
IL NUCLEARE
Per quanto possa sembrare strano, non tutti sanno chel’Italia ha un trascorso abbastanza significativo di produzione di energia nucleare. La storia del nucleare nel nostro paese è iniziata nel 1963, con la costruzione della prima centrale, a Latina. Seguirono, nel giro di neanche un decennio, le centrali di Sessa Aurunca, Trina e Caorso. Già nel 1966 l’Italia era il terzo paese per produzione di energia nucleare al mondo, dopo Usa e Inghilterra. Poi nel 1987 il mondo intero fu scosso dal disastro di Černobyl’ e l’energia nucleare si rivelò all’improvviso per quello che è: un pericolosissimo ordigno pronto ad esplodere in qualsiasi istante. In Italia si decise di correre ai ripari indicendo un referendum. Quasi 30 milioni di elettori accorsero alle urne per bandire definitivamente, così almeno speravano, le centrali nucleari dal nostro paese. Nel 1990 l’ultima centrale venne dismessa. Dunque è durata poco più di vent’anni l’esperienza nucleare italiana, ma questi sono bastati a produrre scorie radioattive di cui il paese non sa come liberarsi, che ancora oggi inquinano mari e terreni coltivati.
Poi, a 18 anni di distanza, con il decreto-legge numero 112 del 2008 il Governo ha deciso di tornare indietro, annullando la volontà dei cittadini e reintroducendo l’energia nucleare. Il decreto è stato poi convertito nella legge 133/2008, approvata dal Senato con 154 voti a favore, un solo voto contrario e un solo astenuto, con Pd e Idv che hanno abbandonato l’Aula al momento del voto. A poco sono valse le proteste ed i ricorsi intentati dalle regioni: il nucleare in Italia “s’ha da fare”.
Il problema maggiore che si sono trovati ad affrontare il Governo e la potente lobby del nucleare, è stato come convincere le persone – in buona parte le stesse che nell’87 dissero di no – che il nucleare è cosa buona e giusta; come mascherare la belva da cucciolo. Ecco allora che, scervellandosi, si sono inventati una sequela di fandonie persino più colossali ed abbondanti di quelle sull’acqua.
Un’ottima ricognizione è quella fornita da Legambiente in un ampio contributo che rendiamo disponibile a lato di questo articolo. Alcune sono menzogne spudorate: “il nucleare è una fonte di energia rinnovabile”, “il nucleare sarà la prossima fonte energetica del futuro nel mondo”; è ovvio che il nucleare non è un’energia rinnovabile in quanto si basa sullo sfruttamento di una materia prima, l’uranio, presente in natura in quantità finite (per non dire scarse), e di conseguenza è altrettanto palese che l’energia del futuro non sarà quella nucleare. Altre più sottili: “il nucleare è pulito”, “il nucleare aiuta a ridurre il surriscaldamento del pianeta”; certo il nucleare è più pulito rispetto ad una centrale a carbone in termini di emissioni, ma come vedremo le perdite radioattive in seguito agli incidenti ed il problema delle scorie rendono quella nucleare un’energia tutt’altro che pulita. Altre ancora, infine, erano considerate quasi dei dati di fatto assodati prima che l’ennesimo disastro, quello di Fukushima, svelasse al mondo intero la loro natura menzognera: “il nucleare di nuova generazione è sicuro”, “un disastro come quello di Černobyl’ non potrà più ripetersi”.
certo il nucleare è più pulito rispetto ad una centrale a carbone in termini di emissioni, ma come vedremo le perdite radioattive in seguito agli incidenti ed il problema delle scorie rendono quella nucleare un’energia tutt’altro che pulita. Altre ancora, infine, erano considerate quasi dei dati di fatto assodati prima che l’ennesimo disastro, quello di Fukushima, svelasse al mondo intero la loro natura menzognera: “il nucleare di nuova generazione è sicuro”, “un disastro come quello di Černobyl’ non potrà più ripetersi”.
Questa sequela di luoghi comuni e falsità serve a coprire le tre grandi aree problematiche che riguardano il nucleare: la sicurezza, lo smaltimento delle scorie e l’antidemocraticità.
La sicurezza. Dicevamo che la lobby dei nuclearisti era quasi riuscita a convincere il mondo sulla sicurezza delle nuove centrali nucleari. È stato necessario un altro disastro di portata planetaria per svelare le fragili basi su cui poggiavano i loro teoremi. Ma Černobyl’ e Fukushima sono solo due dei casi più eclatanti di una miriade di incidenti che costellano la storia dell’energia nucleare. In 50 anni si sono verificati circa150 incidenti nucleari, di cui 14 compresi fra i livelli 4 e 7 della scala di pericolosità stilata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Il fatto è che la presunta sicurezza delle centrali si basa su una concezione di rischio relativa a ciascuna zona. In Giappone, ad esempio, nessuno pensava che potesse arrivare un terremoto superiore agli 8,5 gradi della scala Richter, dunque le centrali erano progettate per resistere a scosse fino a quella entità. Poi è arrivato un sisma di 8,9 e le strutture non hanno retto. Le centrali italiane saranno costruite per resistere a delle scosse di circa 7,1 gradi, ma nessuno ci assicura che un giorno non arriverà un sisma più potente. Quello della sicurezza, poi, non è certo l’unico problema relativo all’energia nucleare. Forse è il più eclatante, probabilmente non il più pericoloso.
Lo smaltimento delle scorie. I rifiuti delle centrali nucleari, le cosiddette scorie, restano radioattive per un tempo che supera i200mila anni. In queste poche parole sta racchiuso l’aspetto più oscuro e spaventoso dell’energia nucleare. È evidente infatti che, per quanto si affannino in molti a ribadire la sicurezza dello stoccaggio delle scorie, non esiste nessun materiale, né il vetro, né l’acciaio (attualmente i due materiali più usati per contenere i rifiuti radioattivi) capaci di durare tutto questo tempo. Stiamo caricando delle bombe ad orologeria sulle spalle delle generazioni a venire. Ci abbiamo riempito il mare, rimpinzato il ventre della terra. La follia di questa operazione risulta evidente da un dibattito attualmente in corso fra i “filosofi” del nucleare: se sia meglio segnalare la presenza delle scorie alle future generazioni o nasconderle in luoghi dove si pensa che nessuno andrà a scavare. Da una parte c’è chi ipotizza di costruire degli enormi segnali di pericolo in un linguaggio comprensibile alle future civiltà in corrispondenza delle discariche di scorie, poste in genere a grandi profondità in bolle di argilla. Dall’altro c’è chi si chiede se una costruzione non possa invece sortire l’effetto contrario, ovvero attirare l’attenzione e spingere ad indagare, scavando; dunque, se non sia meglio stipare i rifiuti tossici in luoghi il più possibile anonimi e privi d’interesse. Ma chi può prevedere come sarà un luogo fra 200mila anni? Chi può immaginare come sarà il mondo allora? È come se l’uomo di Neanderthal si fosse dovuto preoccupare di comunicare con noi: siamo sicuri che avremmo recepito il messaggio?
L’antidemocraticità. Un’ultima area problematica relativa all’energia nucleare è quella della mancanza di democrazia nella sua gestione. Le centrali nucleari, nel mondo, sono sotto il direttocontrollo degli eserciti o di collegi specifici, che possono decidere quali informazioni diramare, quali tenere segrete. Come ammette Renaud Abord de Chatillon, ingegnere membro del Corps des Mines (il collegio che controlla il nucleare in Francia), “l’industria del nucleare non sa che farsene della democrazia, è simile ad un’aristocrazia repubblicana. E dove c’è aristocrazia non c’è spazio della democrazia”. La segretezza che circonda il nucleare ha indotto molti a pensare che il nucleare civile, quello usato per la produzione di energia, nella maggior parte dei casi non sia che una mera copertura per i programmi nucleari militari. Come sostiene il fisico Amory Lovins, “l’elettricità in una centrale nucleare non è che un sottoprodotto”.
Per fermare il ritorno del nucleare in Italia il quesito referendario presentato dall’Italia dei Valori propone di abrogare l’articolo 7, comma 1, lettera d del decreto-legge 112 del 2008, che prevede la “realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”.
CONNESSIONI
Lungi dall’essere due temi distanti l’uno dall’altro, acqua e nucleare presentano una fitta rete di connessioni. L’acqua infatti è sempre il primo elemento a fare le spese dell’inquinamento radioattivo, e lacontaminazione delle falde acquifere da parte delle scorie nucleari è ad oggi uno dei rischi maggiori per il pianeta. Nell’attuale cataclisma Giapponese l’acqua del mare nei pressi della centrale di Fukushima è stata uno dei rilevatori più lampanti del tasso di contaminazione raggiunto (la radioattività era di 7,5 milioni di volte superiore al normale).
Inoltre è con l’acqua che si raffreddano le centrali e nell’acqua vengono lasciate riposare per 5-10 anni le barre di uranio dopo essere state utilizzate nelle centrali. Dunque sbarrare un sì contro il nucleare significa anche garantirsi un accesso ad un’acqua sicura e non contaminata, mentre riaffermare che l’acqua è di tutti significa anche avere il controllo sugli usi che se ne fanno e sul suo stato. Se l’acqua è privatizzata, niente impedisce a chi gestisce una centrale nucleare di controllare localmente la risorsa idrica, di modo da bypassare i controlli e poter riversare liberamente i liquami radioattivi.
DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA
Vorrei concludere questa panoramica con una considerazione sul valore simbolico dello strumento referendario all’interno del processo di riappropriazione di due beni comuni fondamentali come l’acqua e l’energia. Il referendum è uno strumento di democrazia diretta, l’unico – se si escludono le leggi di iniziativa popolare, così poco considerate in Parlamento – che permette ai cittadini di dire la loro, di incidere sulla configurazione societaria senza passare per interposta persona.
Ma il referendum è anche il punto culminante di un cambiamento sociale di cui tutti noi ci possiamo fare portavoce. Un cambiamento che è già in atto e che afferma che non tutto può essere considerato una merce, che esistono dei beni che appartengono a tutti e degli argomenti su cui tutti hanno il diritto di prendere decisioni. Il compito che ci spetta non si può ridurre all’atto di andare a votare. Quello sarà solo l’ultimo atto. Se vogliamo veramente riappropriarci della nostra facoltà decisionale, di quella sovranità che ci è assegnata dalla costituzione e sottratta, ogni giorno, da chi usa la politica come uno strumento per curare i propri interessi, dobbiamo darci da fare fin da adesso. Dobbiamo immettere le nostre conoscenze in rete, fare rete noi stessi. E per reti non intendo semplicemente il web, o internet; internet è solo un esempio di rete. La rete è piuttosto una forma, un modello sul cui stampo si configurano le relazioni sociali contemporanee. Dunque mettere un contenuto in rete significa condividerlo all’interno delle proprie reti di relazioni sociali, con i mezzi di cui si dispone. Si può fare un video e metterlo su Youtube, o realizzare un progetto assieme ad altre persone, così come si possono condividere le proprie informazioni con il barista che ti prepara il caffè la mattina, o con il fornaio o i colleghi di lavoro. Solo così sarà possibile diffondere il cambiamento. Solo così potremo sperare che il 12 e 13 giugno 25 milioni di italiani e più escano di casa e vadano a votare per i referendum.
fonte: Il Cambiamento.it
Questo articolo è già stato letto 4489 volte!